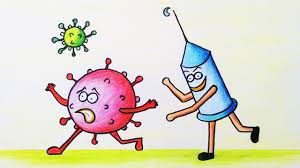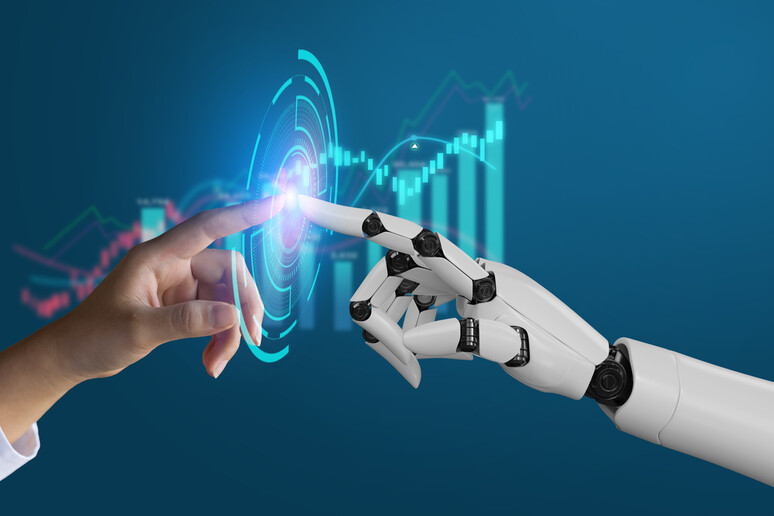NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI
LESIONI AD UN DIPENDENTE NEL CORSO DI UNA RAPINA.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 febbraio 2021 n. 5255, afferma la responsabilità datoriale per la mancata installazione di sistemi di protezione, in caso di lesioni ad un dipendente durante una rapina.
La Corte dichiara che in caso di lesioni ad un dipendente nel corso di una rapina presso un ufficio postale, il datore di lavoro è responsabile per non aver istallato efficaci sistemi di protezione. A fronte della difesa della società secondo cui nessuna norma specifica impone l’istallazione di dispositivi di controllo in ingresso o la configurazione di ambienti separati e protetti per il settore valori per un ufficio postale che custodisce in genere poco denaro contante, la Corte ribadisce la regola generale della massima cautela anche al di là di quelle specificatamente previste dalla legge. A seguito di rapina, durante la quale un dipendente veniva malmenato, quest’ultimo agiva in giudizio nei confronti del datore di lavoro per richiedere il risarcimento del danno biologico ed esistenziale, conseguente all’accaduto, ottenendo la condanna della parte datoriale nei primi due gradi di giudizio. La Cassazione, adita dal soccombente, rileva che la responsabilità imprenditoriale per la mancata predisposizione di sistemi di tutela del lavoratore, discende o da norme specifiche ovvero, ove queste non siano rinvenibili, dalla regola generale ai sensi dell’art. 2087 c.c. secondo cui, l’imprenditore, nell’adottare le misure necessarie alla tutela dell’integrità fisica e personalità morale dei prestatori di lavoro, deve tenere conto della particolarità del lavoro, della realtà aziendale in concreto e del rischio ad essa connesso. Vengono qui in rilievo, i valori apicali dell’ordinamento giuridico, che impongono la tutela della salute, sicurezza, dignità e libertà della persona umana, anche sul luogo di lavoro. La Suprema Corte, sposa un’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c., che si giustifica, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi della previsione di cui all’art. 32 della Costituzione, nonché dei principi di correttezza e buona fede durante il rapporto obbligatorio previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, ed infine, ex art. 2043 c.c. in tema di neminem laedere anche in un caso di comportamento omissivo. Pertanto, sussistendo il nesso causale tra il danno e l’evento cagionato dalla mancata adozione di adeguate misure di tutela, la Corte rigetta il ricorso e conferma la soccombenza della società datrice di lavoro.
ESTENSIONE DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI AI DIRIGENTI.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2021, ha ritenuto che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive introdotto dalla norma citata debba estendersi anche ai dirigenti.
Il Tribunale di Roma, valorizzando la ratio dell’art. 46 del d.l. 18/2020, da ravvisarsi nella volontà di scongiurare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche della pandemia possano scaricarsi sui lavoratori in modo automatico, ha ritenuto che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive introdotto dalla norma citata debba estendersi anche ai dirigenti. Come sottolineato dal Tribunale, il richiamo svolto dal citato art. 46 all’art. 3 della L. 604/1966 va correttamente inteso come rinvio alla fattispecie sostanziale, non potendosi assegnare allo stesso funzione di delimitazione della platea dei lavoratori interessati. Una diversa lettura della norma darebbe luogo, infatti, ad un’irragionevole disparità di trattamento, basata unicamente sull’inquadramento dei lavoratori. Il Tribunale accerta dunque la nullità del licenziamento del dirigente, per violazione di norma imperativa e ne ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. La ratio del blocco è di evitare in via provvisoria che le pressoché generalizzate conseguenze economiche della pandemia, si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro; l’adito giudice ritiene che tale esigenza sia di certo comune ai dirigenti che, anzi, sono maggiormente esposti a tale rischio. Ancor più, considerando che ciò pone in limine” un problema di ragionevolezza in considerazione dell’art. 3 della Cost., in quanto questi ultimi si trovano tutelati per quanto riguarda i licenziamenti collettivi; pertanto, la Corte non ravvisa una ragione valida a giustificare il trattamento differenziale per il caso di licenziamento individuale. La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 3 della L. n. 604/66 consente di individuarne la ratio, non nel delimitare l’ambito soggettivo dell’applicazione del divieto, bensì nell’identificare la natura della ragione impassibile di essere posta a fondamento del recesso.
CORRETTO INQUADRAMETO CONTRATTUALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SUFFICIENTE.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 24 febbraio 2021, stabilisce che la retribuzione sufficiente possa essere individuata sulla base di un CCNL diverso da quello applicato dall’impresa.
Il Tribunale accerta il diritto di un lavoratore a percepire le differenze retributive, salvo la quattordicesima mensilità, derivanti dall’applicazione del CCNL “Trasporto merci e Logistica”, in luogo del CCNL “Legno Artigiani”. Stante l’assenza dei presupposti che consentano al datore di applicare tale secondo CCNL, il Giudice individua il CCNL applicabile a fronte delle mansioni svolte dal lavoratore e in forza dell’art. 36 della Costituzione. Il Giudice, qualificando come contratto di appalto di servizi di trasporto e non come mero contratto di trasporto il rapporto contrattuale intercorso tra il datore di lavoro e l’impresa presso la quale il lavoratore svolgeva l’attività, accerta la responsabilità solidale di quest’ultima ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003. Il potere/dovere del Giudice di sostituzione nell’individuazione dell’ammontare retributivo rispondente alle caratteristiche di sufficienza e proporzionalità rispetto al lavoro svolto dal dipendente, sussiste ai sensi del co.2 dell’art. 1419 c.c., conseguentemente alla nullità della clausola retributiva del contratto di lavoro che fa riferimento al CCNL errato, per il caso di specie, per contrarietà a norma imperativa (art.36 Cost.).
LICENZIAMENTO NELLE PICCOLE IMPRESE.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2 febbraio 2021, solleva questione di legittimità costituzionale sostenendo che il criterio soglia del numero dei dipendenti sia obsoleto: all’esame della Corte costituzionale anche il regime di (debole) tutela del licenziamento nelle piccole imprese, previsto per il contratto a tutele crescenti.
La serie dei giudizi di costituzionalità sul Jobs Act, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018, è destinata ad arricchirsi di un nuovo importante capitolo. Il Tribunale di Roma solleva la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost., dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, nella parte in cui impone un limitatissimo range – da tre a sei mensilità di retribuzione – entro il quale il giudice può individuare l’indennizzo per un licenziamento che si riveli privo di giustificazione, intimato da un datore di lavoro “minore”, intendendosi per tale quello che non supera la soglia occupazionale fissata dall’art. 18, commi 8 e 9 Stat. Lav. (principalmente, il limite dei 15 dipendenti). Il limite delle sei mensilità di indennizzo entrerebbe in contrasto con i criteri di adeguatezza e dissuasività dell’indennizzo già sottolineati dalla Corte nelle sentenze di questi anni. Osserva il Tribunale, da un lato, che il vecchio regime dell’art. 8 L. 604/1966 prevedeva comunque, anche per le piccole imprese, la possibilità di elevare in certi casi e in relazione all’anzianità di servizio la misura dell’indennizzo, anche fino a quattordici mensilità; dall’altro, che considerati gli attuali modelli organizzativi ed economici, il criterio del numero dei dipendenti non appare più adeguato, in relazione alle esigenze di tutela espresse dalla disciplina dei licenziamenti, rispetto ad altri criteri come quello della dimensione economica dell’attività di impresa.
IL LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE RIENTRA NEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI.
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 7 gennaio 2021, si pronuncia in senso favorevole alla assoggettabilità al blocco del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore.
Il Tribunale afferma che il divieto di licenziamento per ragioni oggettive, introdotto dall’art. 46 del d.l. 18/2020, debba estendersi anche al licenziamento adottato per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Il Giudice giunge a tale conclusione, sia a fronte della natura pacificamente “oggettiva” di tale motivo di recesso, sia considerando l‘onere del datore di lavoro di adottare ogni possibile modifica organizzativa che consenta di scongiurare il licenziamento. Il Tribunale dichiara dunque la nullità del licenziamento con condanna alla reintegrazione. Il licenziamento per inabilità sopravvenuta, secondo concorde giurisprudenza rientra nel giustificato motivo oggettivo. Era tuttavia discusso tra le parti se esso rientrasse o meno nell’applicazione della disciplina del blocco dei licenziamenti, in quanto secondo la difesa della convenuta, esso non avrebbe natura di licenziamento economico e sarebbe indipendente dalle condizioni determinate dalla pandemia.
RILASCIO DEL DURC E COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5825 del 2021, stabilisce il divieto per il giudice ordinario di condannare l’INPS al rilascio del DURC.
Afferma la Corte, che debba escludersi che il giudice ordinario, chiamato a decidere su una controversia in cui un’impresa o un lavoratore autonomo lamenti il mancato rilascio del DURC per presunte irregolarità contributive, possa condannare l’ente previdenziale a rilasciarlo. Infatti, osta al riguardo la previsione dell’art. 4, L. n. 2248/1865, All. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto, l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto, il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo. Dunque, non potendo validamente proporsi davanti al giudice ordinario alcuna domanda di condanna al rilascio del DURC, ma solo – e in presenza di un interesse ex art. 100 c.p.c. all’accertamento di una situazione di “regolarità contributiva”, la Corte cassa parzialmente la sentenza impugnata cassata.
PRIMA PRONUNCIA SUL VACCINO COVID-19.
Il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19 marzo 2021 afferma che non è illegittima la sospensione in ferie forzate di alcuni dipendenti di una RSA che non si sono sottoposti al vaccino.
Dopo settimane di dibattito tra gli operatori, arriva all’attenzione del Giudice bellunese un primo caso: da quel che si comprende dalla pronuncia, alcuni lavoratori di una residenza per anziani non si erano sottoposti al vaccino e per questo il datore di lavoro li aveva sospesi in ferie. Il Tribunale respinge il ricorso d’urgenza proposto dai lavoratori per essere riammessi al servizio, affermando che, dato il loro impiego in mansioni a contatto col pubblico e l’elevato rischio di contagio, l’impresa può e deve adottare misure dirette a tutelarne l’integrità fisica pe via dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.: misure tra le quali ora rientrerebbe, ove disponibile, anche il vaccino. Il Giudice si pronuncia su un caso nel quale era in questione la sola legittimità della sospensione in ferie, poiché dalla pronuncia si desume che, in concreto, non era stata disposta né una sospensione dei lavoratori senza retribuzione, né un licenziamento. Il giudice sostiene per il caso di specie, l’insussistenza del periculum in mora e valorizza l’interpretazione in combinato disposto degli articoli 2109 c.c. – per cui il prestatore ha diritto ad “un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” e 2087 c.c. da cui deriva l’esigenza del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, rilevando che quest’ultima, rientrante nelle “esigenze dell’impresa” risulti prevalente rispetto all’interesse del lavoratore di usufruire delle ferie in un periodo diverso.
PERIODO DI REPERIBILITA’.
La Corte di giustizia, con sentenza 9 marzo 2021, nella causa n. C-344/19, chiarisce che il periodo di reperibilità costituisce orario di lavoro se i vincoli imposti al lavoratore gli impediscano in maniera significativa di dedicarsi ai suoi interessi.
La pronuncia della Corte di giustizia era stata sollecitata da un caso in cui un impiegato tecnico lavorava presso un impianto di trasmissione isolato e molto distante dalla propria abitazione, per cui, in caso di turno di reperibilità, era di fatto costretto a non allontanarsi e fruiva di un locale messo a disposizione dalla datrice di lavoro. In queste condizioni, aveva promosso un giudizio per ottenere il riconoscimento che il periodo di servizio di reperibilità fosse considerato orario di lavoro e come tale retribuito. La Corte di giustizia afferma che non tutte le difficoltà di fatto di una qualche significativa mobilità durante il servizio di reperibilità qualificano quest’ultima come orario di lavoro, ma solo quando durante la reperibilità il lavoratore è giuridicamente obbligato a permanere in luogo diverso dal suo domicilio a disposizione del datore di lavoro per le prestazioni eventualmente richieste (queste si, retribuite come orario di lavoro), senza poter dedicarsi ai propri interessi familiari e sociali. Oppure ancora, nel caso che gli obblighi impostogli siano di tale intensità (ad es. di rendersi disponibile a richiesta immediatamente o con un margine di tempo assolutamente esiguo) siano tali da impedirgli, per altra via, in maniera significativa di dedicarsi ai propri interessi. La Corte precisa che nella sentenza in oggetto, con l’espressione “guardia e prontezza” si intendono in maniera generica i periodi nel corso dei quali il lavoratore resta a disposizione del suo datore di lavoro al fine di poter assicurare una prestazione di lavoro, su domanda di quest’ultimo, mentre invece l’espressione “prontezza in regime di reperibilità” si riferisce, tra tutti i periodi suddetti, a quelli durante i quali il lavoratore non è costretto a restare sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro nel caso di specie avrebbe abusato del ricorso ai periodi di prontezza in regime di reperibilità, con conseguente pregiudizio del diritto del lavoratore di gestire liberamente il proprio tempo, alla luce della corretta interpretazione dell’art.2 punto 1 della direttiva 2003/88 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, valutate le effettive circostanze di fatto del caso di specie.
LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ DEL LAVORATORE.
La Corte di cassazione, con sentenza 9 marzo 2021 n. 6497, si pronuncia sul licenziamento per sopraggiunta inidoneità del lavoratore e impossibilità di ragionevoli accomodamenti per consentirne la ricollocazione.
In un caso in cui, a giustificazione del licenziamento di un dipendente per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, il datore di lavoro aveva addotto l’inesistenza, nel luogo della prestazione, di posti della qualifica dell’interessato e l’assenza, nell’organigramma aziendale dell’ufficio, di altri posti liberi, la Corte, richiamando la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria n. 2000/78/CE, ribadisce che l’azienda avrebbe invece dovuto ulteriormente dimostrare che la destinazione del portatore di handicap nell’ufficio o in altro incarico avrebbe comportato un onere finanziario sproporzionato e comunque eccessivo, anche con riferimento all’eventuale necessità di una qualche formazione professionale del dipendente.
FERIE DOVUTE IN RELAZIONE AL PERIODO TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGGITTIMO E LA REINTEGRAZIONE.
La Corte di cassazione, con sentenza 8 marzo 2021 n. 6319 riconosce come dovute le ferie anche con riferimento al periodo tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione.
Nel giudizio promosso da una lavoratrice licenziata e poi reintegrata, la questione del suo diritto a godere delle ferie con riferimento al periodo intercorrente tra il licenziamento poi dichiarato illegittimo e la reintegrazione giudiziale era stata risolta in senso negativo dalla Corte d’appello, in dichiarata adesione alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 28270/08), sulla base della considerazione che le ferie e i ROL spettano solo in caso di lavoro effettivo. Dopo aver interpellato la Corte di giustizia sulla conformità o non di tale orientamento al diritto dell’Unione, la Corte di cassazione muta radicalmente orientamento e, aderendo alla decisione della Corte comunitaria, afferma che le ferie spettano anche con riferimento al periodo di non lavoro per fatto non imputabile al lavoratore e quindi anche nell’ipotesi considerata. Conseguentemente, in caso di successiva cessazione legittima del rapporto, spetta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute anche in relazione al periodo in questione. L’adita Corte di Lussemburgo (Prima Sezione), aveva infatti, con sentenza del 25.06.2020 emessa nelle cause riunite C-762/18 e C-37/19, ha dichiarato che l’art.7, paragrafo 1 della direttiva 2003/88 CE del Parlamento europeo e del consiglio, concernente l’orario di lavoro “deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell’annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite, per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro”. La Corte ha ribadito altresì che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio del diritto sociale dell’Unione, espressamente sancito dall’art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cui l’art. 6 paragrafo 1 TUE attribuisce medesimo valore giuridico dei Trattati.
ACCERTAMENTO DELLA TITOLARITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO NELL’APPALTO.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2021 stabilisce che se il lavoratore chiede l’accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo al committente, è onere del sostanziale utilizzatore della prestazione provare l’esistenza di un genuino rapporto di appalto.
L’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo al committente, se funzionale alla tutela ex art. 18 Stat. lav., può avvenire nell’ambito del c.d. “Rito Fornero”. La Corte, confermando la pronuncia di primo grado, ritiene che quando il lavoratore abbia svolto la prestazione lavorativa a vantaggio del committente, spetti a questo provare l’esistenza di un genuino contratto di appalto, senza che incomba sul lavoratore l’onere di provare chi abbia esercitato il potere direttivo. Ove, come nel caso in oggetto, manchi il titolo e non sia provato lo schermo formale del contratto di appalto, conformemente a quanto affermato dalla Cass. 29889/2019 “consegue l’individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa”, in base alla norma inderogabile dell’art. 2094 c.c., che si riferisce alla collaborazione “nell’impresa”, alle dipendenze dell’imprenditore, tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione. In ogni caso, l’onere della prova della genuinità del contratto di appalto, non può gravare sul lavoratore, anche a norma dell’art.29 co.3-bis del d.lgs. n. 276 del 2003.
TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 3 febbraio 2021 considera che non è soggetta a decadenza entro 60 giorni l’impugnazione del trasferimento, quando quest’ultimo configuri un mero escamotage del datore di lavoro per aggirare l’ordine di reintegrazione del lavoratore.
La Corte d’appello accerta l’illegittimità del licenziamento irrogato a un lavoratore, motivato dal rifiuto di quest’ultimo di svolgere l’attività lavorativa presso un’altra sede, a seguito di trasferimento. La Corte, riformando la sentenza di primo grado, ravvisa, nel trasferimento imposto dal datore, un mero strumento rispetto al reale intento di aggirare, in frode alla legge, l’ordine di reintegrazione disposto con sentenza per un precedente licenziamento. Essendo quest’ultimo il vero obiettivo della società e non già il trasferimento del dipendente, la Corte ritiene che il lavoratore non decada dall’impugnazione del licenziamento per non aver impugnato il trasferimento entro il termine di sessanta giorni. Prevale dunque, secondo la Corte, l’interesse di giustizia del lavoratore, sull’interesse del datore di lavoro, qualora si accertato l’intento fraudolento di quest’ultimo, con conseguente non rilevabilità dello scaduto termine di decadenza per il lavoratore. Conformemente all’orientamento della Cassazione (Cass. 29007/2020) richiamato nella sentenza, infatti, l’avere tempestivamente impugnato l’atto finale della condotta illecita, ovvero il licenziamento, esonera il lavoratore dalla necessità di contestare l’illegittimità del provvedimento emanato dalla società datrice nell’esercizio dello jus variandi, ossia il trasferimento, in considerazione dello stretto legame logico-giuridico intercorrente tra i due provvedimenti nell’ambito della complessa fattispecie che definisce la frode alla legge.